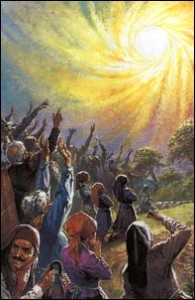Lettera da un matrimonio

Dott. Carmine Paternostro
Soffia il silenzio su case, agitando i grigi fumi di comignoli sparsi, solleva polvere da strade e
contrade, domina su quella, una volta ferrata, che esiliava in terre lontane o in guerra i tanti fratelli,
affidati all’oblio di una storia impietosa.
Sono ricordi di bimbo, memorie indelebili, come cicatrici che hanno segnato quei tempi. Il lontano
percorso di tappe, che ha scritto la storia locale, muta, custodita nel silenzio dell’anima, riaffiora in
qualche stagione. E, in era di Covid, rifletto. Sul mio volto affiora un larvato sorriso perché, in
fondo, il malefico virus ci ha appena sfiorato e, sdegnato, fuggendo, ha preferito lidi migliori, più
ricchi. La povertà è stata la nostra ricchezza.
Tante memorie di momenti diversi fioriscono nei corsi e ricorsi, cari al Gianbattista, traduttore
d’Omero: onde alternanti di colori diversi. Sorvolo perché il mio animo è pervaso dalla diversità
fluttuante di sentimenti e dalla coniugazione dello ieri e dell’oscura luminosità dell’odierno.
Bambini festosi, rumorosi, cinguettanti come uccelli di primavera, riappaiono in mente. Spesso
erano privi di scarpe, di un fazzoletto per lenire un naso colante, con qualche goccia di tosse. Allora
già navigava quel virus comune, da sempre con corona reale, che i libri dicevano coronavirus. Poi
ha deciso di mutare il vestito. E’ diventato Sars insidioso. Lo abbiamo ignorato ed oggi si presenta
più forte e temuto. Alle sue nozze invita, suadente, la gente e si coniuga una, più volte per garantirsi
una prole e trafiggere ancora, come un’Amazzone.
E, affondando nella storia plebea, mi sovviene un matrimonio, vissuto da infante.
Come dimenticare il ricevimento, dopo il giuramento di fusione perenne? A noi bimbi interessavano
pasticcini, i “savoiardi”, la torta nuziale, profumata d’uova nostrane di galline vaganti, a beccare in
strada, orfana dei frastuoni e schiamazzi di rade auto lente e, ove era frequente lo sbadiglio di note
stonate d’asini, in andata o ritorno dai campi. A noi bimbi era concesso solo l’odore dei
“bicchierini” d’augurio. Il liquore era appannaggio dei “grandi”.
Sullo spiazzo antistante la Chiesa, tanti ragazzi, vestiti di abiti mortificati, consunti e riciclati per
trasferimento gerarchico da un fratello all’altro, erano attratti dai confetti e da qualche moneta
augurale, lanciati verso gli sposi. Nel procedere del lungo corteo nuziale, all’agonia della lira, sul
mio capo pioveva, improvvisa, da un balcone dell’ultimo piano, una moneta da cento, metallica. Fu
sorpresa e dolore per l’impatto imprevisto e per l’addio a quelle belle monete, geneticamente
italiane.
Ma un matrimonio partiva da molto lontano. Sistemare una femmina era impegno gravoso.
Necessitava snellire la nutrita famiglia ed avviare i pargoli, ritenuti maturi, alla vita autonoma, auto
sostentamento, al duro lavoro. Le donne, consacrate devote a mariti, talora ubriachi o vagabondi,
ma il più delle volte, tradizionalmente fedeli, responsabili, laboriosi e prolifici, erano votate agli
impegni domestici. Non c’era Tv e, dopo il lungo lavoro diurno, un materasso, imbottito di foglie
secche di spighe, adagiato su un letto di tavole, diventava sede ospitale di un’incessante e sonora
programmazione anagrafica.
La conoscenza avveniva spesso per foto, che varcava le onde impetuose di un Oceano divisorio ed,
all’approvazione del migrato, seguiva il matrimonio per procura. Le più indigenti chiedevano in
prestito alle vicine di casa o alle comari più facoltose un vestito o addirittura una pelliccia, per
posare eleganti e mostrarsi più belle sul quel pezzo cartaceo incolore, decisivo alla conquista in
America. Avrebbero, poi, conosciuto il loro primo viaggio, su lente navi d’esportazione, fino allo
sposo, per sempre.
In paese, di poche risorse, era duro fornire la dote, un pezzo di terra, un’umile casa, un giaciglio allo
sposo promesso.
Spesso il genitore moltiplicava il duro lavoro nei campi, in bottega o al servizio giornaliero di altri.
La madre si impegnava a cucire, a servire in casa di possidenti voraci, scendere al fiume, munita di
sapone nostrano, con un cestone di panni sul capo, effettuare, cantando, il bucato e concludere in
casa la pesante giornata. In molti casi si conviveva nell’unico discreto stanzone, con una vecchietta
invalida, vedova o sola, nella promessa di ereditare quel modesto tugurio. Questa gente, quest’umile
gente a me cara, possedeva un letto a più piazze, un grosso cassone, ceste e panieri di paglia, arnesi
di strenua fatica, un focolare accogliente a mo’ di caverna, un Crocifisso sul muro, tanta serenità e
voglia di vivere. Acqua, servizi igienici? Ad ogni angolo c’era una fontana fluente di poetica acqua
dei monti e per i più fortunati una stalla, con un asino, che, tacito gustava la paglia.
Come onde inquiete del mare, il vissuto di tanta gente del volgo, i volti anneriti d’attinico si
frangono e rifrangono sui fragili scogli della mia mente commossa.
Quanti impegnarono case, terreni per garantire un contratto nuziale alla figlia? Le madri erano
orgogliose di mostrare il corredo, partorito in ore notturne da mani sapienti, virtuose. Ma quel
corredo spesso diventava esiziale: perdita di averi, risparmi, sacrifici. Segnava la loro miseria,
l’umiliazione, l’emigrazione. Il possidente, non dicasi nobile, come amava autocelebrarsi, nel
giorno pattuito per la restituzione del prestito, guarda caso, era assente da casa e, come premeditato,
confiscava quanto impegnato dal malcapitato plebeo. Questi erano i nobili, i presuntuosi proprietari
terrieri del paesello, ironicamente “arcinfanfari” e asini a scuola. Qualche famiglia di nobiltà
verace, offuscata, in dignitosa penuria sfiorava le strade, vivendo delle modeste prestazioni offerte
dal giorno. Dai loro visi traspariva accettazione, pacatezza, serenità, onestà. L’abito bianco di
questa rispettabile gente passava in successione alle figlie minori o veniva conservato in valige
cartacee o alti cassoni, affogati nell’aspro odore di naftalina. Spesso, scucito e ricreato, veniva
riproposto a chi seguiva nell’atteso rito cerimoniale. Ogni fanciulla, nel presentarsi allo sposo,
vestita di bianco, con fiori d’arancio indicava purezza, candore, allora richiesti. Gli invitati alle
nozze, contribuivano con regali d’uso domestico o con pezzi di biancheria. Si dava sostegno e
praticità alla nuova vita incipiente… Esalavano gli ultimi fumi di guerra… Partecipazione,
condivisione e solidarietà tenevano uniti. Tante vecchiette, aprendo il sorriso, mostravano la
carenza di un dente frontale o la penuria dei più, ma espandevano gioia, allegria, partecipazione ben
auguranti. Era un mondo romantico, diverso, di cui sono stato testimone con nostalgia, rammarico e
qualche limpida lacrima.
Feste, matrimoni erano l’occasione di nuovi incontri tra giovani, possibilità di colloquio e…
chissà… una probabile replica di legame per sempre.
Naturalmente, era consuetudine che i promessi sedessero in salotto a distanza, vigilati dalla madre o
sorella della donzella. Una passeggiata, agli occhi critici della gente si svolgeva sempre con madre
o sorella interposta tra i due. Insomma si mantenevano le dovute distanze…
Ma sono stato partecipe anche di nozze tra benestanti. Gli impiegati stavano bene in quei tempi. La
lira stava emergendo in forza e salute, prima che i politici dell’ultima era avrebbero inventato la sua
distruzione.
Ricordo il matrimonio di due colleghi dei miei genitori, insegnanti: ricevimento in casa, dolci,
brindisi, balli, allegria. Ad un certo punto gli sposi spariscono. Ritornano dopo alcuni minuti con
abiti mutati, normali, salutano. Sotto li attende la macchina da noleggio. Li porterà alla stazione
delle rimpiante Ferrovie Calabro Lucane per la luna di miele, mi spiega mia madre, termini che, da
infante, non potevo capire.
Erano avviati al viaggio di nozze, a progettare l’erede e poi altri. Al ritorno, “novità?” sarebbe stata
la prima domanda delle allegre comari!
In quei tempi ne nascevano tanti di bimbi, ma si moriva, purtroppo, di più.
Intanto la festa, gestita da amici e parenti dei colombi in volo felice, in musica e danze continua. I
tacchi dell’avvocato si sbizzarriscono in strane movenze di ballo, con dame liete di ondeggiare nei
vestiti fluenti ed occhi indiscreti a guardare…
Terminata la festa, stanchi, si ritorna al giaciglio. Ma, dopo qualche giorno, rientra anzitempo la
coppia. La sposa è malata, altrove ha contratto la febbre, forse influenza. Oggi avremmo parlato,
con tema, di Covid, ma il pandemico virus non era ancora sbocciato. Con qualche giorno di letto,
brodo ustionante, i premurosi vicini di casa e parenti, sgranocchiando qualche residuo di dolce, si
adoperavano per contribuire ad una guarigione veloce. Solidali, era come tenersi per mano. La
morte non faceva paura, dopo i disastri di una guerra luttuosa e la diffusa mortalità dei bambini.
Non c’era la scienza di oggi, i tanti vaccini, ma un sorriso colorato di cielo, un arcobaleno, che
chiamavamo “destino”.
In fondo, il Covid d’oggi nelle difficoltà, limiti, contraddizioni ci ha restituito il desiderio d’essere
noi con e per gli altri, in una festa mutata.
Avevo appena sei anni! “Glufè” mnemoniche: è la Letteratura di un matrimonio tra i tanti, disperso
nella storia dei tempi, che non sarà dei manzoniani Renzo e Lucia, ma realmente avvenuto.