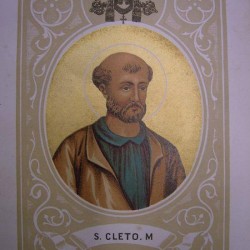“Lo schiaffo” di Domenico Santoro
È un racconto, completamente autobiografico, scritto qualche anno fa, da Domenico Santoro, infermiere professionale impiegato nella torre cardiologica dell’ospedale di Salerno. È ambientato negli anni della scuola, passati ormai da molto tempo. Quindi è ricostruito sul filo della memoria. Si tratta, o meglio, si trattava di un gruppo di studenti dell’Istituto Tecnico Industriale, ambientato nel casertano, dove però non mancavano alunni provenienti dal beneventano o da Acerra. Il capo banda, per così dire, anzi il leader degli Acerrani, era un certo Gigino, il quale, usando le mani, doveva dare spesso dimostrazione di essere il più forte, per mantenere alto l’onore di capo. Di lui e delle sue prodezze si parlava dappertutto nella scuola, ma l’autore di questo racconto sostiene di non averlo visto quasi mai fare a botte con qualcuno, tranne quando le suonò di santa ragione ad un certo Vinciguerra, nel cortile della scuola.
Gigino si dava le arie di essere un guappo ed apparteneva ad una famiglia di guappi. Di cognome si chiamava Nocera ed era l’ultimo rampollo di una famiglia di commerciati di porci. Il padre, Tommaso, era un gigante alto circa un metro e ottantacinque. Una volta, nel corso di una transazione di affari tenutasi ai mercati generali, aveva mandato in coma per tre giorni un tizio con un solo pugno in faccia. Era stato condannato a sei mesi di carcere con il beneficio della condizionale. Per dimostrare che era veramente un guappo, capo zona, circolava per le strade del paese a bordo di una Alfa Romeo 1750, che lasciava in sosta dove gli pareva, anche in seconda o in terza fila, aperta, con un pacco di Marlboro sul cruscotto in bella vista. Nessuno doveva toccare niente, e in realtà nessuno si accostava a quella macchina. Soltanto un tossicodipendente, una volta, convinto che quelle sigarette fossero state lasciate lì a beneficio di chi aveva voglia di fumare, entrò nella macchina, accese una sigaretta e la fumò tranquillamente. Quand’ecco che una mano grossa quanto un badile, si abbatté sul suo collo come una morsa d’acciaio e fu fatto volare dal finestrino. Così anche lui capì che in futuro avrebbe dovuto tenersi lontano da quella macchina.
Gigino non era altrettanto forte, né altrettanto alto e robusto; aveva un fisico più snello ed elegante, ma esigeva rispetto per la sua provenienza e, se questo non fosse bastato, disponeva di una pistola calibro 7,65, che qualche volta tirava fuori per far paura ai suoi possibili contendenti.
Gigino rispettava, in una certa misura, soltanto Vittorio Farina, mentre odiava tutti gli altri, i quali fingevano di rispettarlo, proprio perché di lui avevano una forte paura. Vittorio Farina, a differenza di tutti gli altri Acerrani, era timido, schivo e perso nei suoi pensieri. Nei suoi occhi si leggeva la tristezza del giovane, afflitto da un’angoscia infinita e da un’incipiente calvizie. Farina, nel contempo, ammirava ed invidiava Gigino, ma sapeva che lui non sarebbe stato un guappo. Probabilmente era un pesce fuor d’acqua, nato in un momento sbagliato; non desiderava diventare guappo, anzi, si sarebbe accontentato di avere una ragazza sincera da amare e di vivere una vita tranquilla.
I ragazzi avevano una professoressa di matematica originale ed un po’ ridicola, nel senso che appariva piuttosto minuta in tutte le sue parti fuorché nel sedere. Quando spiegava alla lavagna, si sollevava sui tacchi, mettendo in evidenza il suo lato B. Al momento della correzione dei compiti, fioccavano i tre e i quattro. Soltanto qualcuno riusciva a raggiungere la sufficienza e questo qualcuno era il suo alunno prediletto. La cosa funzionò per un anno, ma l’anno successivo arrivarono da un’altra classe due giovani prodigio, uno che parlava come un avvocato, così bene che avrebbe potuto preparare un discorso anche per il Presidente della Repubblica, ed un altro che, quanto a parlare, valeva zero, ma con i numeri ci sapeva molto fare. Entrambi oscurarono la fama di Gabriele D’Agostino, ex alunno prediletto.
Al termine della lezione la professoressa di matematica chiedeva alla classe se tutti avessero capito e tutti rispondevano di sì, ma nessuno aveva capito niente. In realtà, l’insegnante si rendeva conto che a capire erano stati soltanto in pochi, ma le conveniva fingere di credere alla classe, altrimenti avrebbe dovuto rispiegare il tutto.
Assentatosi, per ragioni di salute, il professore di misure elettriche, lo sostituì per un anno un giovane docente, tale Leopoldo Lanzetti, al suo primo incarico importante come supplente. Sia per inesperienza, sia per mancanza di capacità di comando, le sue lezioni si svolgevano nel caos più assoluto. “Al confronto – dice l’autore del racconto – i mercati generali sembravano l’interno di una chiesa”. Era stato sfortunato ad incontrare una classe di mascalzoni, niente affatto scolarizzati, che lo tormentò per tutto l’anno scolastico. Alla fine dell’anno, però, partecipando al consiglio di classe, ne fece promuovere soltanto sei; nella sezione di ottobre ne fece bocciare undici. Fu, insomma, un macello e fu anche la vendetta del professore.