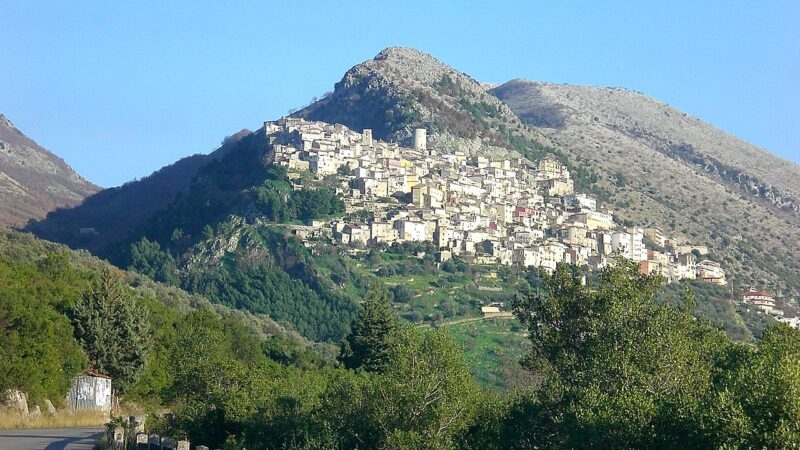Stati Uniti, il momento dell’autocritica
Amedeo Tesauro
 I presidenti in uscita, si sa, possono approfittare degli ultimi momenti per togliersi i sassolini dalle scarpe, certi dell’immunità di fronte alle conseguenze. Ecco allora che Barack Obama, a pochi mesi dal termine del suo secondo mandato, non le manda a dire e anzi fa i conti con tutti in un lungo intervento su The Atlantic. Obama contro gli alleati, quelli arabi come l’Arabia Saudita ma anche, e soprattutto dato il peso dell’uscita, Francia e Inghilterra, corresponsabili del maggior errore della sua presidenza: l’intervento in Libia nel 2011. Cinque anni dopo il presidente degli Stati Uniti si dice pentito dell’affare Gheddafi, ammettendo di aver generato il caos con un’operazione poco lungimirante. L’Italia lo sa bene, il colonnello non era certo un santo e rimpiangere i dittatori non è bello, ma in termini di realpolitik svolgeva una funzione irrinunciabiledi controllo e gestione in quell’area, limitando certi fenomeni e impedendo l’esplodere di altri. NicolasSarkozy si gettò nell’operazione libica con forza trascinando gli alleati nella missione, Obama oggi rimpiange l’aver dato credito all’ex presidente francese, così come a DavidCameron, entrambi incapaci di garantire un adeguato seguito all’intervento militare. Già, il caos successivo, prima di scatenarlo sarebbe stato conveniente avere in cantiere un progetto preciso, la cui assenza si fa sentire ancora oggi. Le parole di Barack Obama pongono una questione a più ampio raggio sul ruolo statunitense, quel ruolo auto-assegnatosi di difensori del mondo occidentale e dei suoi valori, il mito degli U.S.A come potenza arbitro delle sorti mondiali, chiamato in causa e spinto a intervenire in territori complessi. L’inapplicabilità di questo modus-operandi è palese, impossibile farsi trascinare in ogni conflitto sul globo, impraticabile il post-operazione con strascichi decennali, il perenne stato di conflitto militare in cui vivono gli Stati Uniti è una consuetudine da correggere. Il presidente statunitense rivendica perciò il non intervento in Siria nel 2013, un cambio di rotta che non ti aspetteresti dal gigante americano, un atto che suscitò polemiche tra gli alleati esteri ma anche nel proprio partito, a cominciare da Hillary Clinton. La probabile vincitrice delle primarie democratiche era convinta intervista, sia nel caso Siria sia in Libia, lasciando presagire che i giorni in cui Stati Uniti andavano in giro per il mondo a diramare questioni estere siano tutt’altro che finiti. Ma la presa di coscienza c’è, netta e chiara: Obama vuole un presidente che sappia di non poter risolvere tutto (I want a presidentwhohas the sensethatyoucan’tfixeverything) e consapevole delle controindicazioni della forza bruta e dell’interventismo atto a ripristinare l’ordine, una politica alla lunga dannosa per gli il paese (What I thinkis not smart is the idea thatevery time thereis a problem, wesend in ourmilitary to impose order. We just can’t do that). C’è la sensazione forte che le esperienze degli ultimi quindici anni abbiano mostrato impietosamente i limiti della guerra perenne statunitense, eppure dall’altro lato la sussiste la constatazione che fermarsi sia difficile e allo stato attuale delle cose non possibile: l’ISIS, definito come il Joker di Batman, deve essere combattuto. Ma combatterlo porterà a nuove conseguenze in cui restare impigliati per decenni, un peso che gli Stati Unit ora sentono tutto. Un circolo vizioso dal quale non si vede l’uscita.
I presidenti in uscita, si sa, possono approfittare degli ultimi momenti per togliersi i sassolini dalle scarpe, certi dell’immunità di fronte alle conseguenze. Ecco allora che Barack Obama, a pochi mesi dal termine del suo secondo mandato, non le manda a dire e anzi fa i conti con tutti in un lungo intervento su The Atlantic. Obama contro gli alleati, quelli arabi come l’Arabia Saudita ma anche, e soprattutto dato il peso dell’uscita, Francia e Inghilterra, corresponsabili del maggior errore della sua presidenza: l’intervento in Libia nel 2011. Cinque anni dopo il presidente degli Stati Uniti si dice pentito dell’affare Gheddafi, ammettendo di aver generato il caos con un’operazione poco lungimirante. L’Italia lo sa bene, il colonnello non era certo un santo e rimpiangere i dittatori non è bello, ma in termini di realpolitik svolgeva una funzione irrinunciabiledi controllo e gestione in quell’area, limitando certi fenomeni e impedendo l’esplodere di altri. NicolasSarkozy si gettò nell’operazione libica con forza trascinando gli alleati nella missione, Obama oggi rimpiange l’aver dato credito all’ex presidente francese, così come a DavidCameron, entrambi incapaci di garantire un adeguato seguito all’intervento militare. Già, il caos successivo, prima di scatenarlo sarebbe stato conveniente avere in cantiere un progetto preciso, la cui assenza si fa sentire ancora oggi. Le parole di Barack Obama pongono una questione a più ampio raggio sul ruolo statunitense, quel ruolo auto-assegnatosi di difensori del mondo occidentale e dei suoi valori, il mito degli U.S.A come potenza arbitro delle sorti mondiali, chiamato in causa e spinto a intervenire in territori complessi. L’inapplicabilità di questo modus-operandi è palese, impossibile farsi trascinare in ogni conflitto sul globo, impraticabile il post-operazione con strascichi decennali, il perenne stato di conflitto militare in cui vivono gli Stati Uniti è una consuetudine da correggere. Il presidente statunitense rivendica perciò il non intervento in Siria nel 2013, un cambio di rotta che non ti aspetteresti dal gigante americano, un atto che suscitò polemiche tra gli alleati esteri ma anche nel proprio partito, a cominciare da Hillary Clinton. La probabile vincitrice delle primarie democratiche era convinta intervista, sia nel caso Siria sia in Libia, lasciando presagire che i giorni in cui Stati Uniti andavano in giro per il mondo a diramare questioni estere siano tutt’altro che finiti. Ma la presa di coscienza c’è, netta e chiara: Obama vuole un presidente che sappia di non poter risolvere tutto (I want a presidentwhohas the sensethatyoucan’tfixeverything) e consapevole delle controindicazioni della forza bruta e dell’interventismo atto a ripristinare l’ordine, una politica alla lunga dannosa per gli il paese (What I thinkis not smart is the idea thatevery time thereis a problem, wesend in ourmilitary to impose order. We just can’t do that). C’è la sensazione forte che le esperienze degli ultimi quindici anni abbiano mostrato impietosamente i limiti della guerra perenne statunitense, eppure dall’altro lato la sussiste la constatazione che fermarsi sia difficile e allo stato attuale delle cose non possibile: l’ISIS, definito come il Joker di Batman, deve essere combattuto. Ma combatterlo porterà a nuove conseguenze in cui restare impigliati per decenni, un peso che gli Stati Unit ora sentono tutto. Un circolo vizioso dal quale non si vede l’uscita.