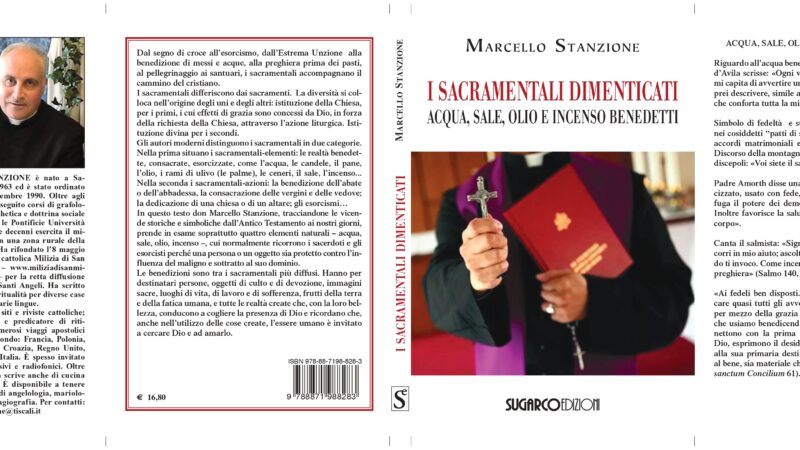Santa Caterina da Genova e gli angeli buoni e cattivi
don Marcello Stanzione
 Caterina Fieschi conosciuta come Madonna Caterinetta, che i contemporanei chiamarono “serafina” e i posteri “Dottoressa del Purgatorio”, nacque a Genova nel 1447, ultima di cinque figli che il patrizio guelfo, Giacomo Fieschi, vicerè di Napoli per Renato d’Angiò, ebbe da Francesca Di Negro. Il suo casato aveva dato alla repubblica dogi, e alla Chiesa i papi Innocenzo IV e Adriano V, oltre 93 cardinali e 300 tra vescovi e prelati. Sentendosi attratta dalla penitenza, a otto anni Caterina incominciò a dormire su un duro pagliericcio e a fare uso per guanciale di un pezzo di legno; a dodici ricevette da Dio il dono dell’orazione; a tredici avrebbe abbracciato volentieri la vita religiosa con la sorella Limbania, Canonichessa Lateranense nel monastero di S. Maria delle Grazie, se vi fosse stata accettata. Per ragioni di politica familiare dovette, invece, orfana di padre da un anno, andare in sposa, nel gennaio del 1463, al nobile ghibellino Giuliano Adorno, il quale aveva avuto cinque figli naturali. Accanto ad un marito iracondo e dissoluto, la santa visse i suoi primi cinque anni di vita matrimoniale nella più desolante solitudine. Nei cinque anni successivi cercò un onesto svago nelle feste e nei ricevimenti dell’elegante società del tempo, ma essendosi affievolito in lei lo spirito di orazione, non vi trovò che noia e disgusto. Il 20-3-1473 chiese a S. Benedetto la grazia di restare ammalata per tre mesi, ma non fu esaudita. In seguito alle istanze della sorella Limbania avvicinò il confessore del monastero, ma non riuscì ad aprirgli l’animo suo perché, appena inginocchiata, ricevette al cuore la ferita di un immenso amor di Dio e una visione così chiara delle sue miserie che, come alienata dai sensi, poté soltanto gridare dal fondo del suo cuore: “Non più mondo! Non più peccati”. Ritornata a casa, ella vide il Redentore con la croce in ispalla e grondante sangue, in tanta copia, che la casa ne sembrava inondata. “Vedi questo sangue? – le disse Egli – E’ stato sparso tutto per amor tuo e in soddisfazione dei tuoi peccati”. “O amore, mai più, mai più peccati!” , gemeva Caterina ogni volta che ripensava a quella visione. Dopo la confessione generale, per quattro anni la santa si diede a penitenze tanto straordinarie che “parean cose da morire”, confessò ella stessa. Nello stesso tempo prese a fare sei ore di preghiera al giorno, inginocchiata per terra, a servire i malati e i lebbrosi prima a domicilio con le Dame della Misericordia, e poi negli ospedali. Per vincere il naturale ribrezzo che provava a contatto delle loro piaghe tante volte giunse a baciarle. Per soddisfare pienamente da sé la divina giustizia si astenne dal lucrare le indulgenze e ricusò la soddisfazione altrui. Tre giorni dopo il suo ravvedimento si accostò al banchetto eucaristico. Il desiderio della Comunione quotidiana non cessò più in lei finchè visse. Perché tenesse compagnia a Gesù nel deserto, per ventitrè anni le fu concesso in Quaresima e in Avvento di vivere per quaranta giorni soltanto della Comunione. Se per compiacere il confessore o i familiari ingeriva qualcosa, il suo stomaco lo rigettava prontamente. Per venticinque anni Iddio fu il suo unico maestro che l’indusse a fare sempre la sua volontà. Confermò la santa: “ Mi sento spinta interiormente a fare questo o quello, senza alcuna resistenza, e io credo che Dio voglia così; ma Egli non vuole che abbia al suo,posto nell’anima oggetto alcuno”. Un giorno la esortò all’esercizio delle virtù con queste parole: “Figliuola, non dir mai: voglio e non voglio; non dir mai mio, ma sempre nostro; non ti scusare, ma siì sempre pronta ad accusarti”. Poiché Caterina seguiva, docile, le ispirazioni della grazia, il Signore la favoriva di visioni e di estasi paradisiache che duravano tre o quattro ore di seguito. Nel 1478 i Protettori dell’ospedale Pammatone, fondato a Genova nel 1420 dal giureconsulto Bartolomeo Bosco, chiesero a Caterina che prestasse la sua opera a favore dei malati colà ricoverati. La santa non ricusò, memore di quanto Gesù le aveva detto: “Voglio anche che quando sarai chiamata per fare opere di pietà tu ci vada sempre e a infermi e a poveri di ogni sorta, né voglio che giammai ricusi, e gli farai tutto quello ch’io ti darò per istinto… E quando per far questo sarai chiamata, ancorché tu fossi a parlar con Dio, voglio lasci il tutto e va presto a chi ti chiama e dove sarai condotta”. Prese, quindi, in affitto una casa con giardino vicino all’ospedale, evi si stabilì con il marito che era riuscita a convertire a Dio, nel 1476, e a fargli abbracciare il Terz’Ordine Francescano dopo una vita di sperperi e di disordini. Nel 1489, dopo undici anni di umili servizi prestati agli infermi del Pammatone, vi fu eletta Rettora per il reparto femminile. Durante i trentadue anni della sua vita ospedaliera, per cinque volte Genova fu colpita dalla peste. In quella che scoppiò nel 1493 anch’essa fu assalita dal morbo, da cui guarì a stento, perché non aveva saputo astenersi dal baciare una terziaria contagiata che aveva visto “con la bocca piena di Gesù”. Quattro anni dopo le morì il marito che aveva condiviso con lei il servizio ai malati. Aveva avuto l’assicurazione da Dio che la sua anima era salva. Per vivere e pagare l’affitto di casa le bastarono le poche sostanze ereditate. Negli anni passati al servizio dell’ospedale non accettò ricompensa di sorta. Fu sovente udita ripetere: “S’io mangio, o bevo; s’io vado, sto o penso; s’io muoio o non muoio, in ogni momento della mia vita, tutto voglio che sia in Dio, e per Dio nel prossimo”. Nonostante le assillanti occupazioni e le frequenti malattie trovò sempre il tempo da dedicare alle sue pratiche di devozione. Ogni mattina si comunicava benché fosse disapprovata e criticata da molti perché allora le persone pie non facevano la comunione che una volta al mese. Sovente durantela Messaandava in estasi, ma al momento della Comunione rientrava in sé. Il suo volto talora emetteva scintille di fuoco come un ferro rovente cavato dalla fucina. Per mitigare il grande ardore che l’abbrucciava, cercava di distrarsi nelle varie occupazioni dell’ospedale. Talvolta correva a nascondersi, ed emetteva altissime grida sembrandole di trovare in esse un refrigerio all’insopportabile fuoco che la divorava. A cinquant’anni una debolezza estrema la costrinse a lasciare i digiuni straordinari ed ecclesiastici. I più illustri medici dichiararono che l’infermità di cui soffrì fino alla morte era di natura soprannaturale. Il sacerdote Cattaneo Marabutto (1528), che frequentava l’ospedale di Pammatone, per volere del cielo divenne allora suo direttore, confessore, confidente e incaricato di affari. Più tardi ne scriverà la vita con l’aiuto di altri discepoli di lei quali Ettore Vernazza. La santa non poteva fare a meno di lui tanto le era diventato fastidioso il tormento dello spirito e della carne insidiata forse da un cancro o da una nevrosi. E’ questo il periodo delle grandi prove mistiche di Caterina. Alcune volte l’assaliva una sete e una fame ardente, ma quando le veniva offerto l’alimento si sentiva sopraffatta dall’inappetenza e dalla nausea. Un anno prima della morte in una settimana non mangiò quanto altri avrebbe consumato in u pasto. L’ardore del suo amore era così intenso che la pelle, nella regione del cuore, aveva assunto il colore dello zafferano. Talora si contorceva sotto lo spasimo del fuoco divino gridando: “Amore, io non ne posso più!”. Chi allora la toccava si sentiva scottare. Se si ponevano carboni accesi sul suo braccio, si vedeva ardere la sua carne senza che sentisse dolore alcuno perché era sopraffatta dal fuoco divino. Altrettanto le succedeva quando stringeva tra le dita i rami spinosi
Caterina Fieschi conosciuta come Madonna Caterinetta, che i contemporanei chiamarono “serafina” e i posteri “Dottoressa del Purgatorio”, nacque a Genova nel 1447, ultima di cinque figli che il patrizio guelfo, Giacomo Fieschi, vicerè di Napoli per Renato d’Angiò, ebbe da Francesca Di Negro. Il suo casato aveva dato alla repubblica dogi, e alla Chiesa i papi Innocenzo IV e Adriano V, oltre 93 cardinali e 300 tra vescovi e prelati. Sentendosi attratta dalla penitenza, a otto anni Caterina incominciò a dormire su un duro pagliericcio e a fare uso per guanciale di un pezzo di legno; a dodici ricevette da Dio il dono dell’orazione; a tredici avrebbe abbracciato volentieri la vita religiosa con la sorella Limbania, Canonichessa Lateranense nel monastero di S. Maria delle Grazie, se vi fosse stata accettata. Per ragioni di politica familiare dovette, invece, orfana di padre da un anno, andare in sposa, nel gennaio del 1463, al nobile ghibellino Giuliano Adorno, il quale aveva avuto cinque figli naturali. Accanto ad un marito iracondo e dissoluto, la santa visse i suoi primi cinque anni di vita matrimoniale nella più desolante solitudine. Nei cinque anni successivi cercò un onesto svago nelle feste e nei ricevimenti dell’elegante società del tempo, ma essendosi affievolito in lei lo spirito di orazione, non vi trovò che noia e disgusto. Il 20-3-1473 chiese a S. Benedetto la grazia di restare ammalata per tre mesi, ma non fu esaudita. In seguito alle istanze della sorella Limbania avvicinò il confessore del monastero, ma non riuscì ad aprirgli l’animo suo perché, appena inginocchiata, ricevette al cuore la ferita di un immenso amor di Dio e una visione così chiara delle sue miserie che, come alienata dai sensi, poté soltanto gridare dal fondo del suo cuore: “Non più mondo! Non più peccati”. Ritornata a casa, ella vide il Redentore con la croce in ispalla e grondante sangue, in tanta copia, che la casa ne sembrava inondata. “Vedi questo sangue? – le disse Egli – E’ stato sparso tutto per amor tuo e in soddisfazione dei tuoi peccati”. “O amore, mai più, mai più peccati!” , gemeva Caterina ogni volta che ripensava a quella visione. Dopo la confessione generale, per quattro anni la santa si diede a penitenze tanto straordinarie che “parean cose da morire”, confessò ella stessa. Nello stesso tempo prese a fare sei ore di preghiera al giorno, inginocchiata per terra, a servire i malati e i lebbrosi prima a domicilio con le Dame della Misericordia, e poi negli ospedali. Per vincere il naturale ribrezzo che provava a contatto delle loro piaghe tante volte giunse a baciarle. Per soddisfare pienamente da sé la divina giustizia si astenne dal lucrare le indulgenze e ricusò la soddisfazione altrui. Tre giorni dopo il suo ravvedimento si accostò al banchetto eucaristico. Il desiderio della Comunione quotidiana non cessò più in lei finchè visse. Perché tenesse compagnia a Gesù nel deserto, per ventitrè anni le fu concesso in Quaresima e in Avvento di vivere per quaranta giorni soltanto della Comunione. Se per compiacere il confessore o i familiari ingeriva qualcosa, il suo stomaco lo rigettava prontamente. Per venticinque anni Iddio fu il suo unico maestro che l’indusse a fare sempre la sua volontà. Confermò la santa: “ Mi sento spinta interiormente a fare questo o quello, senza alcuna resistenza, e io credo che Dio voglia così; ma Egli non vuole che abbia al suo,posto nell’anima oggetto alcuno”. Un giorno la esortò all’esercizio delle virtù con queste parole: “Figliuola, non dir mai: voglio e non voglio; non dir mai mio, ma sempre nostro; non ti scusare, ma siì sempre pronta ad accusarti”. Poiché Caterina seguiva, docile, le ispirazioni della grazia, il Signore la favoriva di visioni e di estasi paradisiache che duravano tre o quattro ore di seguito. Nel 1478 i Protettori dell’ospedale Pammatone, fondato a Genova nel 1420 dal giureconsulto Bartolomeo Bosco, chiesero a Caterina che prestasse la sua opera a favore dei malati colà ricoverati. La santa non ricusò, memore di quanto Gesù le aveva detto: “Voglio anche che quando sarai chiamata per fare opere di pietà tu ci vada sempre e a infermi e a poveri di ogni sorta, né voglio che giammai ricusi, e gli farai tutto quello ch’io ti darò per istinto… E quando per far questo sarai chiamata, ancorché tu fossi a parlar con Dio, voglio lasci il tutto e va presto a chi ti chiama e dove sarai condotta”. Prese, quindi, in affitto una casa con giardino vicino all’ospedale, evi si stabilì con il marito che era riuscita a convertire a Dio, nel 1476, e a fargli abbracciare il Terz’Ordine Francescano dopo una vita di sperperi e di disordini. Nel 1489, dopo undici anni di umili servizi prestati agli infermi del Pammatone, vi fu eletta Rettora per il reparto femminile. Durante i trentadue anni della sua vita ospedaliera, per cinque volte Genova fu colpita dalla peste. In quella che scoppiò nel 1493 anch’essa fu assalita dal morbo, da cui guarì a stento, perché non aveva saputo astenersi dal baciare una terziaria contagiata che aveva visto “con la bocca piena di Gesù”. Quattro anni dopo le morì il marito che aveva condiviso con lei il servizio ai malati. Aveva avuto l’assicurazione da Dio che la sua anima era salva. Per vivere e pagare l’affitto di casa le bastarono le poche sostanze ereditate. Negli anni passati al servizio dell’ospedale non accettò ricompensa di sorta. Fu sovente udita ripetere: “S’io mangio, o bevo; s’io vado, sto o penso; s’io muoio o non muoio, in ogni momento della mia vita, tutto voglio che sia in Dio, e per Dio nel prossimo”. Nonostante le assillanti occupazioni e le frequenti malattie trovò sempre il tempo da dedicare alle sue pratiche di devozione. Ogni mattina si comunicava benché fosse disapprovata e criticata da molti perché allora le persone pie non facevano la comunione che una volta al mese. Sovente durantela Messaandava in estasi, ma al momento della Comunione rientrava in sé. Il suo volto talora emetteva scintille di fuoco come un ferro rovente cavato dalla fucina. Per mitigare il grande ardore che l’abbrucciava, cercava di distrarsi nelle varie occupazioni dell’ospedale. Talvolta correva a nascondersi, ed emetteva altissime grida sembrandole di trovare in esse un refrigerio all’insopportabile fuoco che la divorava. A cinquant’anni una debolezza estrema la costrinse a lasciare i digiuni straordinari ed ecclesiastici. I più illustri medici dichiararono che l’infermità di cui soffrì fino alla morte era di natura soprannaturale. Il sacerdote Cattaneo Marabutto (1528), che frequentava l’ospedale di Pammatone, per volere del cielo divenne allora suo direttore, confessore, confidente e incaricato di affari. Più tardi ne scriverà la vita con l’aiuto di altri discepoli di lei quali Ettore Vernazza. La santa non poteva fare a meno di lui tanto le era diventato fastidioso il tormento dello spirito e della carne insidiata forse da un cancro o da una nevrosi. E’ questo il periodo delle grandi prove mistiche di Caterina. Alcune volte l’assaliva una sete e una fame ardente, ma quando le veniva offerto l’alimento si sentiva sopraffatta dall’inappetenza e dalla nausea. Un anno prima della morte in una settimana non mangiò quanto altri avrebbe consumato in u pasto. L’ardore del suo amore era così intenso che la pelle, nella regione del cuore, aveva assunto il colore dello zafferano. Talora si contorceva sotto lo spasimo del fuoco divino gridando: “Amore, io non ne posso più!”. Chi allora la toccava si sentiva scottare. Se si ponevano carboni accesi sul suo braccio, si vedeva ardere la sua carne senza che sentisse dolore alcuno perché era sopraffatta dal fuoco divino. Altrettanto le succedeva quando stringeva tra le dita i rami spinosi
delle rose del suo giardino. Sfinita e consumata dal continuo martirio e da atroci sofferenze, benché apparentemente sana o senza febbre, sospirava: “Signore, che vuoi più che faccia in questo mondo? Io non vedo, non odo, non mangio, non dormo, non so quello che mi faccia, né quello che mi dica…Io mi trovo essere come una cosa morta e vivo per essere tenuta quasi per forza in vita. Non è creatura che m’intenda…e perciò più non posso vivere con le creature in terra”. Si ritiene che prima di morire Caterinetta abbia avuto il dono delle stimmate invisibili con i relativi lancinanti dolori. Morì il 5-9-1510 dopo aver detto con Gesù in croce: “Padre, nelle tue mani affido il mio spirito”. Fu canonizzata il 16-6-1737 da Clemente XII. Il 6-4.1675 Clemente X ne aveva già riconosciuto il culto e, nel 1684, la repubblica di Genova l’aveva proclamata sua particolare patrona. Riguardo agli angeli buoni e cattivi la santa genovese che scrive molto sul Purgatorio fa solo pochi alcuni riferimenti nelle sue opere che sono tre scritti: Vita mirabile; Dialogo e Trattato sul Purgatorio e dichiara: “Se Dio non mi aiutasse, non potrei mai fare qualche cosa di buono, perché nell’agire male mi ritrovo peggiore di Lucifero; e tutto questo lo vedo così chiaramente che, se anche tutti gli angeli riconoscessero in me qualcosa di bene, non lo crederei, perché vedo chiaramente che tutto il bene sta solo in Dio, e in me, senza la divina grazia, sta solo difetto”. “Quest’anima illuminata diceva di aver avuto una visione dell’amor proprio per cui vide d’avere, per suo maestro e signore, il demonio. Lo vedeva quasi per essenza, spiritualmente o corporalmente, nell’uomo, al punto che sarebbe stato meglio chiamarlo “odio proprio”, per tutto il male che spinge l’uomo a compiere, per poi, alla fine, precipitarlo nell’Inferno”. “L’uomo, pertanto, non dovrebbe temere se non l’offesa a Dio e tutto il resto, in comparazione di questo , dovrebbe essergli come se non ci fosse né mai dovesse esserci; così dell’Inferno con tutti i suoi demoni e i suoi tormenti”. “ Ebbe anche in quel tempo molte visioni di angeli; qualche volta si vedeva ridere con loro, senza però parlare, e secondo quello che poi raccontò, vide la letizia con la quale in tante pene la consolavano, mostrandole l’apparato del suo trionfo. Vide anche i demoni, ma ne ebbe poca paura, perché era sicura e perfettamente unita nella carità con Dio, che scaccia via ogni timore”. “Dio non potendo sopportare una benché minima imperfezione, odia questo misero e disgraziato peccato, che solo impedisce che questo suo amore operi in noi, dove perfino i diavoli, se non fosse in loro questo peccato, brucerebbero d’amore divino”. “Dico che Dio ama tanto perfettamente le sue creature, che non si trovò né mai si troverà intelletto tanto angelico che possa comprenderne una minima parte, e se anche Dio volesse fare sì che un’anima ne fosse in grado, bisognerebbe allora che le facesse il corpo immortale, per quanto, per natura, è inconcepibile”. “Vedo l’esempio di Lucifero, come si trova per essersi diretto verso questo amore perverso, ma ancor molto meglio lo vedo in noi, attraverso il nostro padre, Adamo, che ci ha condotti con questo suo seme – quasi incurabile ai miei occhi -, per cui l’uomo ne ha piene le vene, i nervi e le ossa, e non può dire, né pensare, con l’anima o con il corpo, alcun atto che non sia pieno di quel velenoso amore, tale da contaminare perfino le operazioni fatte, dette e pensate per la perfezione dello spirito. di modo che per tanta incurabile infermità, altro rimedio non vedo che Dio. E se Egli non lo facesse per sua grazia di qua, lo farà a nostro dispetto , purificare poi di là nel Purgatorio, essendo necessario, prima di vedere il puro volto di Dio, che purifichiamo talmente ogni nostra macchia da rimanerne del tutto mondi e puri”. “Una volta, a causa del grande ardore che si sentiva dentro, chiamò Lucifero e gli disse: “Voglio ragionare con te sopra un caso che mi passa per la mente. dimmi, che cosa è più importante, l’intero Inferno con tutti i suoi tormenti e i suoi guai – anche se tu solo li avessi tutti in te – o a quell’anima che ama con amore puro e senza macchia un solo bruscolino posto in mezzo, come impedimento, a questo suoi vero amore?”. Invece della risposta, le fu mostrato nella mente come fosse molto più intollerabile l’offesa, per quanto minima possa essere, che non l’Inferno di Lucifero”.