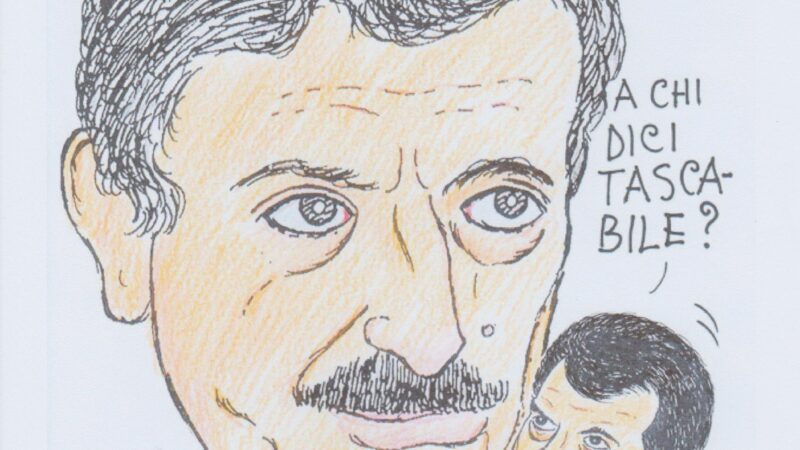La tristezza del corpo e dell’anima
Aurelio Di Matteo
 Fin dai lontani tempi del liceo, un verso è rimasto inciso in modo indelebile nella mia significazione profonda dell’emotività. Un verso che Mallarmé scrisse nel 1865. Uno di quei versi che per se stessi costituiscono non tanto una poesia, ma un universo semantico.
Fin dai lontani tempi del liceo, un verso è rimasto inciso in modo indelebile nella mia significazione profonda dell’emotività. Un verso che Mallarmé scrisse nel 1865. Uno di quei versi che per se stessi costituiscono non tanto una poesia, ma un universo semantico.
La chair est triste, hélas! et j’ai lu tous les livres. La carne è triste, ahimè! E ho letto tutti i libri.
Mi era stato spiegato e commentato con riferimento ad una sopraggiunta tendenza lirica, alla cui definizione si adattava un termine inglese, spleen, che, pur nel successivo acquisito significato, nella nostra lingua si banalizza. Non mi convinceva. Non mi rendeva la profonda significazione che avvertivo tra la totalità del sapere e la “tristezza” della carne, con il brivido profondo che suggeriva ed evocava. Quello stesso brivido semantico che ritorna alla memoria ogni volta che mi risuona quel verso.
Evocazione e dubbio della spiegazione, anche quando la confrontavo con la “tristezza dell’anima” espressa nelle parole, drammaticamente suggestive e umanamente protese nella richiesta di “sostegno”, del Cristo nell’orto del Gethsemani, Tristis est anima mea usque ad mortem. L’anima mia è oppressa da tristezza mortale. E in seguito aggiungeva, con la mesta consapevolezza della fragilità umana, “spiritus quidem promptus est, caro autem infirma.” Ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole. Una fragilità che faceva tutt’uno con quella tristezza dell’”anima”, ma non con la certezza granitica dello “spitito”.
Il tutto si ricompose e mi si chiarì leggendo, in un universo di situazioni e di pensiero altri, il passaggio di un libretto in forma di epistolario scritto da Antonio Negri quando era in carcere a Rebibbia, Pipe-line, un capolavoro assoluto di narrazione, di formazione politica e di emozioni.
“Cher David, la morte è il nemico, il corpo l’amico”. Ed è il corpo, nella sua singolarità e nella sua collettività, che impedisce a Negri “la tentazione del suicidio” che sempre ritornava a fronte dell’isolamento e della perdita di umanità della condizione carceraria. “Di contro il corpo non vuole morire, poiché è vita, non cosa che conforta ma cosa che produce: pròfasis di vita è il corpo…….Certo, il corpo è fragile, ma l’estrema povertà è una forza straordinaria”.
In tutti e tre i testi è il pulsare della forza creativa della corporeità che invade l’uomo, è la singolarità nei suoi nessi relazionali con il sé e con gli altri. E ad essa non può non appartenere l’universo emozionale della complessità, a cui il sapere, il pensiero non possono essere estranei. Non c’è asetticità di alcun momento nella pienezza della vita, laddove la corporeità è pur sempre fungente, vive e non si arrende. In Negri è la corporeità che resiste alla mente e determina essa il “pensiero”. E dice, quasi a richiamare questo passaggio, in una bellissima sua lettera dal carcere, che custodisco gelosamente: “la primavera non riesce a vincere la tristezza dell’anima. Ma è difficile resistere alla forza della Natura”. Tutto qui, la morte è il nemico, il corpo l’amico! Soprattutto se vive nella comunità simpatetica di una intersoggettività costituente, richiesta e finalizzata.
Analogamente, la sofferta dicotomia che il Cristo avverte con tutta la consapevolezza dell’uomo nella complessità del suo essere, quella tristezza dell’”anima” ma non dello “spirito” appartiene tutta intera alla “fragilità corporea”, al suo fungere in atto che si trasforma in potenza quando la cupiditas si trasforma in amore, ancor più se intersoggettivo e in “comune”. Tutto ciò, limpidamente espresso in una concreta e vitale significazione, ha trovato successivamente, purtroppo, un’astratta teorizzazione e una codificazione etico-sociale, quando il Potere costituito, politico e religioso ad un tempo, lo ha rielaborato, nel dispositivo, per dirla alla Foucault, del “corpo” e in discorso sulla “carne”, su quanto sia legato alla corporeità, ivi inclusa la connaturale cupiditas, che in tal modo diventa moralmente e giuridicamente peccato. E tutto l’Occidente è vissuto e vive un’artefatta dicotomia che contraddice la pienezza dell’essere persona. A renderlo tale è stato senz’altro l’istituzionalizzazione, politica e religiosa, di una religiosità in sé ardita, innovativa e umanamente rivoluzionaria con la predicazione di una intersoggettività comunitaria fondata sull’agape. Prima che si diffondessero le varie “chiese”, nella visione dell’uomo la corporeità non era mai disgiunta dall’interezza della singolarità. Anzi, nell’antica Grecia la sua cura, connessa alla guerra, allo sport e alla religiosità con la ritualità dei giochi in occasione dei funerali degli eroi, diventava elemento fondamentale della formazione dei giovani. È solo nel pensiero di Platone che si anticipa la dicotomia e, quindi, la subalternità all’altro aspetto della singolarità, in vario modo identificato e declinato, mente, spirito, pensiero, psiche, ecc. La subalternità ben presto diventa disprezzo, negatività e peccato, di cui liberarsi con la mistica e l’ascesi. Un dispositivo sociale per l’esercizio del “potere”, che, però, vestiva la corporeità peccaminosa sempre dei panni al femminile. Le manifestazioni di rifiuto del corpo riguardavano pur sempre le donne. E non a caso il Medioevo fu definito, con riferimento alla santità femminile, il periodo delle “Sante anoressiche”.
E senz’altro aveva ragione il religiosissimo Baruch Spinoza quando in Etica e Trattato teologico-politico affermava: “Dal che deriva che quando gli uomini dicono che questa o quella azione del Corpo è originata dalla Mente, la quale ha dominio sul Corpo, non sanno quello che dicono.”
Corporeità? potenza vitale che eccede l’esperienza vissuta, il quotidiano. E a Spinoza fa eco un non meno religiosissimo Antonio Negri.
Corpo e amore, dunque. Il corpo è fragile, ma riproduce la vita e riproduce il mondo. Il corpo è fragile, ma l’estrema povertà, come l’amore di Francesco, è una forza straordinaria. Il corpo è tutto: non c’è altro che questo mio corpo potente, qui ed ora, su quest’unica terra. È nel corpo che s’innervano le capacità nelle quali trovano legittimità i diritti, che Spinoza chiamava, forse a giusta ragione, virtù, queste potenze del corpo virtuoso che aprono la potenza del Bios al futuro e legittimano l’umana autoaffermazione e la ragionevole autonomia; che limitano la pretesa di onnipotenza del potere e negano la sua pretesa di negare la vita stessa, svilendola come “bene indisponibile”.
La genealogia materialistica dell’amore, espressione del corpo e dei corpi che s’intrecciano, potenza creatrice, cupiditas, è argine alla tristezza quando essa si impadronisce della singolarità fungente.