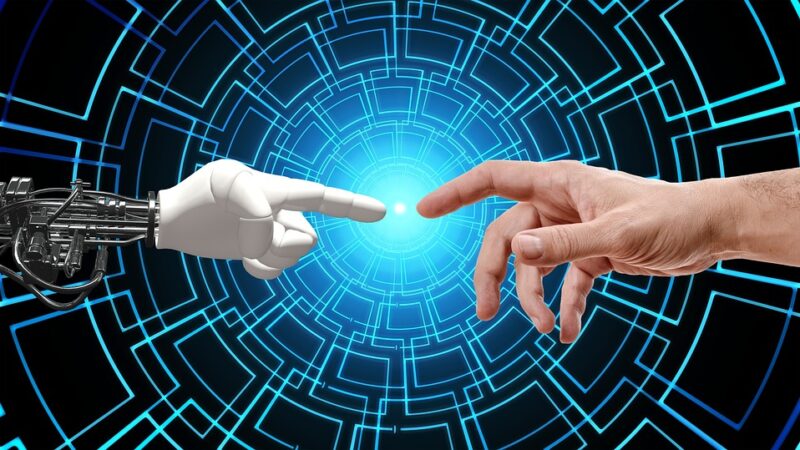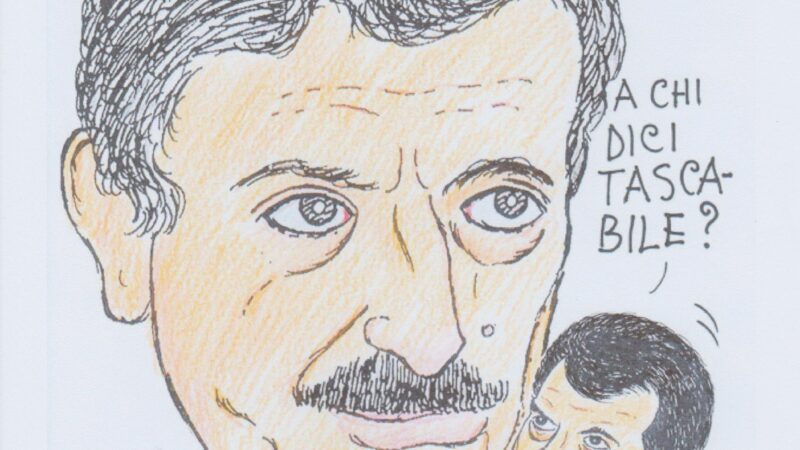Il divo Giulio
La sola volta che vidi Giulio Andreotti da vicino fu al teatro Capitol di Salerno, una mattina di circa 30 anni fa. Fu invitato a presenziare ad un comizio di un noto esponente della Dc locale, in prossimità di non ricordo bene quale elezione. Sembrava fosse giunto al capolinea della sua già lunga carriera politica, nel senso che in pochi, tra le poltroncine di quel parterre, avrebbero immaginato che gli sarebbe toccato in sorte per altre due volte la carica di capo del governo, dopo le cinque precedenti. Ma come egli stesso era solito dire : il potere logora chi non ce l’ha, e lui, il divo Giulio, si è conservato benissimo, per molti lustri. Riassumere in poche righe la vita di Andreotti e tutto quello che ha rappresentato la sua figura, in Italia e nel mondo, sarebbe impossibile, e anche poco rispettoso. Basti dire che il pluri-ministro e presidente del consiglio fu tra i padri della Costituzione del ’48, oltre che tra i fondatori della Democrazia Cristiana, partito che ha simboleggiato meglio e più di chiunque altro, fino alla sua dissoluzione negli anni di mani pulite. Intelligente, ironico all’inverosimile, religioso e, soprattutto, cauto, Andreotti ha attraversato in lungo e in largo 60 anni di storia italiana. Personaggio controverso, non immune da critiche e da sospetti, la sua parabola entrò in fase discendente agli albori della seconda Repubblica, dopo la nomina di senatore a vita, ultimo tassello di una gloriosa ed ineguagliabile carriera. Andreotti subì l’onta di due gravi imputazioni, una a Perugia, dove venne processato con l’accusa di essere stato il mandante dell’omicidio del giornalista Mino Pecorelli, l’altra, per certi versi ancora più infamante, a Palermo, dove fu additato di essere nientemeno che un mafioso di cosa nostra. Per processarlo, la procura siciliana ricorse ad una figura delittuosa mai conosciuta prima e di fatto estranea a qualunque codificazione : il concorso esterno. La notizia destò il giusto clamore, e il racconto di un presunto bacio tra l’imputato Giulio e Totò Riina divenne per diversi anni un vero e proprio tormentone mediatico-giudiziario. Il calvario processuale di Andreotti fu lungo e accidentato, ma vissuto sempre in rigoroso silenzio, nel massimo rispetto della magistratura, e senza indulgere a facili proclami. Fu assolto, in entrambi i procedimenti, in Corte di Cassazione. Ma, come spesso accade, è tra le righe che si nasconde il dettaglio più infido e velenoso. Andreotti venne sì prosciolto dall’accusa di concorso mafioso, ma, in un passaggio delle motivazioni della sentenza, si confermò l’esistenza di un’imprecisata forma di collaborazione tra lui e la mafia. Collaborazione che, essendosi esaurita entro il 1980, sarebbe però caduta in prescrizione. Lasciamo ai giuristi dal palato fine l’interpretazione di quelle poche righe infauste che segnano il confine poco chiaro tra la dignità e l’infamia. Per quanto mi riguarda, non ho mai creduto nella fattispecie giuridica del concorso esterno, condotta, a mio modesto avviso, troppo effimera e sbiadita per concorrere alla privazione della libertà di un uomo. Chiunque, specie a una certa età, non sarebbe sopravvissuto al tormento e alla vergogna per simili processi, al clamore angosciante delle prime condanne poi ribaltate, all’attesa interminabile dei tre gradi di giudizio. Ma Andreotti ce l’ha fatta. Lui sì, ha resistito. Il destino ha voluto concedergli ancora qualche anno, forse il tempo necessario per riabilitarlo e prenotargli un posto nella storia. Ai posteri.