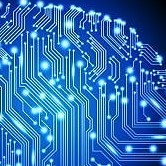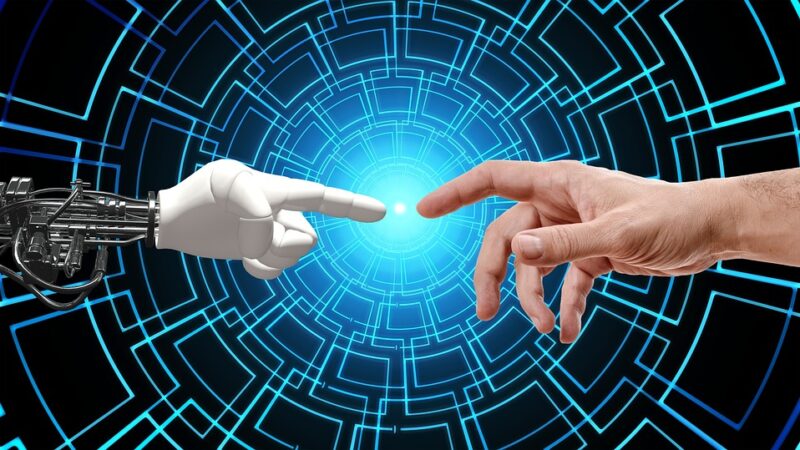Il coraggio dell’utopia
Aurelio Di Matteo
 Ciò che manca oggi alla politica non è l’ideologia, di cui si lamentano i nostalgici dei tempi andati per nascondere l’incapacità di elaborare soluzioni nuove per realtà e problemi nuovi.
Ciò che manca oggi alla politica non è l’ideologia, di cui si lamentano i nostalgici dei tempi andati per nascondere l’incapacità di elaborare soluzioni nuove per realtà e problemi nuovi.
Ciò che manca è il coraggio dell’Utopia. Ciò si riflette – o ne è il riflesso – nella cinematografia, nelle tante fiction televisive, nella narrativa e, di conseguenza, nella quotidianità del pensare e dell’agire. Il tutto condito dall’orizzontalità del botta e risposta, del “mi piace”, che non si nega a nessun post perché non impegnativo, e dell’emoticon o del gif che rimandano ad un’emozione reattiva ormai senza significazione corporea.
Durante il Rinascimento, il territorio che poi fu Italia, toccò vette del pensiero e dell’azione ineguagliabili in tutte le declinazioni della società e dell’umanità, dalla politica all’arte, dal galateo alle scienze, dagli avventurosi viaggi sugli oceani a quelli non meno folli del pensiero. Ciò che allora muoveva la vita, anche quotidiana, era l’Utopia. Ed oggi, se non ci sarà il ritorno all’utopia, anche nel quotidiano, non ci sarà cambiamento e “rinascimento”. Continueremo, come nelle fiction, fermi e rassegnati ad aspettare le prossime puntate, che si concluderanno con l’ultima, sempre lì dove erano iniziate.
L’utopia è considerato il regno dell’impossibile. Max Weber, però, giustamente avvertiva: “Se non si tentasse sempre l’impossibile, il possibile non sarebbe mai raggiunto”. Essa richiama nell’etimologia ciò che non c’è ancora: οὐ–τόπος, un “non luogo”, ma non ciò che non sia possibile far esistere o a cui non aspirare quale motivazione dell’agire.
Gli è che la filosofia, ispiratrice delle elaborazioni che hanno presieduto alle modificazioni dei principi ontologici delle trasformazioni sociali o ne hanno sostenute le forze strutturali propulsive, con la post-modernità ha rinunciato al suo ruolo e alla sua funzione. Ha cessato di essere organica alla società, come lo era nella laica tradizione greca e illuministica o in quella solare ed esuberante del Rinascimento o nell’altra totalizzante a cavallo degli ultimi due secoli. Si è rifugiata nel cantuccio comodo del proprio individualismo “accademico”, produttivo di remunerati consensi di parte. Sedotto dalla celebrità del momento, il filosofo si è ridotto ad occuparsi di ciò che il grande pubblico vuole, di ciò che dà applauso e consenso, insomma del futile e del mutevole. E così i filosofi-intellettuali sono diventati banali intrattenitori di salotti televisivi, laudatores del politico di turno. Eppure quasi tutti hanno letto, illustrato, chiosato e, forse, insegnato Platone.
L’utopia ha sempre accompagnato i momenti di grande crisi o di grandi trasformazioni della società, quasi sempre trasformazioni epocali. Lo fu per Platone, che avendo vissuto la condanna e la morte di Socrate da parte dell’ordine costituito della sua città e la sconfitta, gravida di conseguenze, di Atene da parte di Sparta, ritenne che fosse giunto il tempo di ripensare la struttura della polis e la politica tradizionale. E regalò al pensiero il meraviglioso dialogo de “La repubblica”, in particolare quell’inizio del VII libro con il mito della caverna, quasi sempre additato come “percorso” della conoscenza e non, invece, come percorso politico per il governo di una nuova polis. Non ci sarà soluzione alla cattiva gestione della città fino a quando “i filosofi” non scenderanno tra la moltitudine dei “cittadini prigionieri” per liberarli dalle loro catene. A costo, come fa dire a Socrate che lo aveva sperimentato, di essere derisi o uccisi. Ed egli stesso si mette in gioco con il viaggio a Siracusa, “impegnandosi” nella concreta azione politica, cercando di convertire Dionisio agli “insegnamenti” della filosofia.
E non meno pregni di crisi e di trasformazioni furono i tempi rinascimentali in cui furono elaborate molteplici “utopie”. Tra l’altro la denominazione comparve proprio con Tommaso Moro. Erano i tempi dello sviluppo in senso borghese della grande proprietà terriera, quella formatasi nel Feudalesimo e che Marx chiamò “accumulazione originaria”; tempi in cui il “mercato”, oggi assurto alla sacralità del divino, si espandeva in rapida evoluzione, le grandi organizzazioni statali europee prendevano consistenza e nascevano le prime banche che proprio il Machiavelli definì “uno Stato nello Stato”. Nel contempo si acuivano le contraddizioni sociali con l’impoverimento di masse deprivate di ogni bene o ridotte in condizione di estremo sfruttamento. Ed ecco le grandi utopie politiche, sociali ed urbanistiche ad un tempo di Tommaso Moro (Utopia), di Campanella (La Città del Sole), di Francesco Doni (I Mondi), di Francesco Patrizi (La Città felice), di Ludovico Agostini (La Repubblica immaginaria) e, per finire agli inizi del 1600, di Lodovico Zuccolo (Belluzzi ovvero La città felice), di Traiano Boccalini (Dei ragguagli di Parnaso). E in tutte, come in Platone, indipendentemente dalle immaginarie organizzazioni previste, a caratterizzarne le finalità prevalevano due principi guida fondamentali: la giustizia sociale e la politica intesa come paideia. E a ben vedere, di contro, anche il “realismo politico” di Machiavelli altro non era che l’utopia di una politica senza etica e paideia.
Certo, il coraggio dell’utopia non vuole essere un invito a disegnare nuove polis e nuove immaginarie società, nuovi e perfetti modelli di strutture sociali. È la consapevolezza che devono riacquistare l’intellettuale e la filosofia, abbandonando il cosiddetto “pensiero debole” o “pensiero riluttante”, come diventato da alcuni mesi in Rovatti, rifiutando la piacevolezza del consenso dei salotti televisivi per riprendere il perduto “impegno”, per riscoprire una riflessione critica che sia di supporto per comprendere le cose come stanno e correggere il mondo in cui viviamo.
Ed altrettanto certamente, tra il reale e l’ideale c’è sempre uno scarto contraddittorio, una frattura, una sorda e nascosta lotta; ma la rinnovata riflessione dell’intellettuale-filosofo che si è “sporcato” nelle sofferenze sociali, nelle ingiustizie, nelle disuguaglianze e nelle emarginazioni che il mercato e il capitale finanziario hanno creato, che ha riassunto la sua funzione mostrata nel Mito della Caverna a costo di essere deriso o “ucciso”, potrà almeno impedire che la politica si appiattisca sul reale nella convinzione che questo sia l’unico mondo possibile.